Diagnostica genetica – citogenetica
Equipe
Martina Betti (biologa)
Stefania Bonifacio (biologa)
Claudia Centrone (biologa)
Barbara Minuti (biologa)
Daniela Parrini (biologa)
Sara Iozzi (biotecnologa)
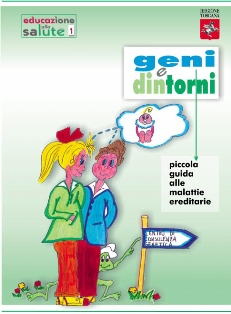
Introduzione alla citogenetica
Il materiale genetico, il DNA, si presenta durante l’accrescimento cellulare come un ammasso disorganizzato non analizzabile. Al momento della divisione, esso si condensa in strutture ordinate, i cromosomi, che sono invece analizzabili. Per questo motivo nell’indagine citogenetica è importante avere cellule in divisione, cosa che si ottiene sia con il metodo diretto sia con il metodo della coltura. Le cellule sono bloccate in un momento particolare della divisione: la metafase. In metafase, infatti, i cromosomi si presentano come delle strutture definite, facilmente individuabili e riconoscibili al microscopio. Dopo aver bloccato le cellule in metafase i cromosomi sono colorati con sostanze che si fissano selettivamente a determinate zone cromosomiche, dando luogo ad un caratteristico aspetto a bande: bande Q, G o R secondo la tecnica di colorazione utilizzata.
La fase successiva comprende l’osservazione al microscopio: i cromosomi di un certo numero di metafasi sono contati, analizzati quindi si compone il cariotipo. In questa ultima fase i cromosomi sono appaiati a due a due in base alle dimensioni, alla posizione del centromero (una strozzatura del cromosoma) e al bandeggio. S’arriva così alla determinazione del cariotipo. Il cariotipo è quindi l’insieme dei cromosomi di un individuo. La determinazione del cariotipo costituisce un’indagine importante in quanto permette di evidenziare eventuali anomalie cromosomiche, sia numeriche (quali trisomie, monosomie e presenza di un marcatore), che strutturali (traslocazioni, delezioni, duplicazioni ed inversioni). Tale indagine si effettua sia sulle cellule fetali (diagnosi prenatale) sia sui linfociti (diagnosi post-natale). L’osservazione al microscopio dei preparati opportunamente colorati è sufficiente per evidenziare e identificare tali anomalie. In alcuni casi è necessario eseguire un’ulteriore analisi, per studiare nei dettagli l’anomalia in questione. Questa tecnica prende il nome di Ibridazione in Situ Fluorescente. Conseguentemente si avrà un prolungamento dei tempi dell’analisi, che potrebbe rendere necessario un ulteriore prelievo di tessuto diverso da quello in esame. L’analisi dell’intero corredo cromosomico non è in grado di evidenziare la presenza di geni difettosi. Pertanto, per la diagnosi di malattie geniche dovranno essere utilizzate tecniche molecolari per lo studio del DNA.
Introduzione alla genetica umana
Ciascuna specie ha un assetto di cromosomi caratteristico: caratteristico è il numero, la lunghezza e la forma dei cromosomi. Anche il numero e la sequenza dei geni (localizzati in una precisa posizione) presenti su di essi è una loro caratteristica.
Il genotipo di un individuo rappresenta la sua costituzione genetica. Il cariotipo rappresenta le strutture morfologiche in cui si organizza il genotipo. Il fenotipo rappresenta l’espressione dei geni sotto forma di un carattere fisico rilevabile. Il genoma rappresenta l’intero assetto dei geni.
Le cellule umane contengono 46 cromosomi. Essi vengono raggruppati in ventitre paia di cromosomi omologhi ciascuno dei quali porta la stessa informazione genetica. Un cromosoma di ciascuna coppia è d’origine paterna mentre l’altro è d’origine materna. I cromosomi omologhi di ventidue coppie, detti autosomi, sono eguali sia nelle femmine sia nei maschi. I cromosomi presenti nella ventitreesima coppia sono diversi nei maschi e nelle femmine e sono responsabile della determinazione del sesso, per tale motivo denominati cromosomi sessuali. Nella femmina i due cromosomi sessuali, chiamati cromosoma X, sono eguali; nel maschio i due cromosomi sessuali sono invece diversi: uno è identico al cromosoma X presente nelle femmine mentre l’altro, di forma più piccola, è detto cromosoma Y.
Tuttavia a seguito di mutazioni, cioè a modificazioni del materiale genetico che hanno come conseguenza una perdita o il cambiamento della funzione del gene stesso, possono verificarsi alterazioni, alcune delle quali individuabili con l’analisi del genotipo, cioè del DNA, ed altre, che possono coinvolgere la struttura del cromosoma o il numero dei cromosomi, le quali vengono messe evidenza dall’esame cromosomico.
Le anomalie cromosomiche possono essere di tipo costituzionale oppure acquisite.
Le anomalie cromosomiche costituzionali, che rappresentano la patologia genetica più comune nella popolazione, originano nello zigote, cellula che deriva dall’unione di un gamete femminile e di uno maschile, sino a che non si divide e diventa l’uovo fecondato. Questo tipo di anomalie possono colpire tutte le cellule dell’organismo; si parla allora di corredo omogeneo. Le mutazioni possono essere presenti soltanto in una percentuale di cellule; in questo caso si ha un corredo detto a Mosaico.
Le anomalie cromosomiche acquisite si limitano ad un tessuto o un organo; possono essere presenti soltanto nelle cellule somatiche e s’instaurano dopo la nascita. Le anomalie cromosomiche somatiche possono essere causate da mutageni ambientali come radiazioni ionizzanti, agenti virali o chimici.
Diagnosi citogenetica prenatale
Quando si esegue
L’indagine citogenetica è eseguita in gravidanza e permette lo studio del cariotipo fetale, eseguita su villo coriale, liquido amniotico o sangue fetale. Tale prestazione in caso di gravidanza a rischio per anomalie genetiche ed anomalie cromosomiche è esente da ticket, come da protocollo regionale. L’analisi si esegue a:
- Madri con età superiore ai 35 anni di età
- Genitori con precedente figlio affetto da anomalia cromosomica o da malattia genetica diagnosticabile
- Genitori portatori di riarrangiamento strutturale o da malattia genetica
- Patologia fetale eco evidenziata
- Indicazioni biochimiche: triplo test
Modalità dell’esame
La diagnosi prenatale permette di rilevare nel feto anomalie cromosomiche, numeriche e strutturali, alle quali sono spesso associate condizioni patologiche. Il prelievo del materiale fetale necessario per tale diagnosi comporta un aumento del rischio di aborto. Di conseguenza l’indagine cromosomica prenatale non dovrebbe essere considerata un’analisi di routine e dovrebbe essere eseguita solo nelle gravidanze a rischio; in questi casi il rischio di dare alla luce un bambino gravemente ammalato è sicuramente maggiore del rischio di provocare un aborto.
La diagnosi prenatale può essere eseguita su tre diversi tipi di materiale fetale:
- Villo coriale
- Liquido amniotico
- Sangue fetale
Dove si effettua
I relativi prelievi possono essere effettuati presso:
- Centro di Medicina fetale e diagnosi prenatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- Centro di Diagnosi Prenatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
- Centro unico di Diagnosi Prenatale Presidio Ospedaliero Palagi della Azienda USL Toscana Centro
Diagnosi citogenetica su materiale abortivo
L’esame citogenetico del materiale abortivo permette di evidenziare eventuali cause genetiche determinanti interruzioni spontanee di gravidanza. Il materiale, che deve pervenire al Laboratorio possibilmente entro 24 ore, deve essere in primo luogo esaminato per assicurare la presenza di materiale di origine fetale, riconoscibile per caratteristiche morfologiche diverse dal materiale di origine materna.
Il percorso standard prevede un’analisi mediante QF-PCR per la ricerca delle aneuploidie 13,18,21,X,Y (I° livello), in caso di negatività si esegue la ricerca delle aneuploidie 15,16,22 (II° livello). Questo permette di eseguire l’esame anche su una piccola quantità di materiale fetale e su materiale non idoneo all’allestimento della coltura cellulare. Per evidenziare la eventuale contaminazione materna è richiesto anche un prelievo di sangue periferico materno. Per particolari indicazioni può essere richiesto l’esame citogenetico convenzionale.
Diagnosi citogenetica post-natale
L’indagine citogenetica permette lo studio del cariotipo ed è eseguita su sangue periferico.
Quando si esegue l’esame
- Soggetti con sospetta sindrome cromosomica o malattia genetica
- Genitori e familiari di soggetti con anomalie cromosomiche
- Soggetti con difetti, ritardo mentale o ritardo d’accrescimento
- Causa di morte nei neonati
- Coppie con figlio con sospetta sindrome cromosomica, deceduto senza diagnosi
- Coppie con poliabortività
- Soggetti infertili
In cosa consiste l’esame
- consulenza genetica nella quale vengono raccolte informazioni sulla famiglia
- prelievo di sangue periferico
![]()
Ultimo aggiornamento
9 Aprile 2024, 08:31
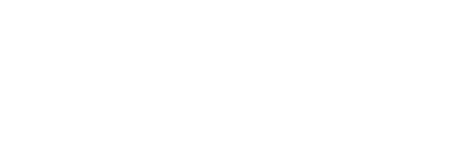 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi